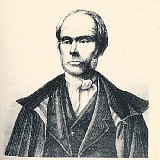| Home | La città | Personaggi | Arte | Miti e leggende | Repertori | Cronologia | Links utili |
|
||||||
|
Antonio Boggia,
il mostro della via Bagnera
di Mauro
Colombo L'inizio dell'orrore: il caso Perrocchio
Inizia
così la terribile storia, costellata di agghiaccianti omicidi, di Antonio
Boggia, che passerà alla storia come il mostro della via Bagnera. La deposizione di un figlio disperatoSecondo la denuncia presentata, tutto ebbe inizio l'anno precedente, quando il Maurier, recatosi una mattina a far visita all’anziana madre, non l'aveva trovata, nonostante le ricerche, né in casa né nella vicina chiesa di San Giorgio al Palazzo, di cui era parrocchiana. Dai custodi del caseggiato, i coniugi Trasselli, aveva finalmente appreso che la donna era partita qualche settimana prima, lasciando detto che si sarebbe recata sul lago di Como. Il Maurier dichiarò che non s'era all'epoca insospettito più di tanto, ben conoscendo infatti le stranezze della madre, con la quale, come egli stesso sottolineò, non correva propriamente buon sangue. Pertanto l'uomo se ne era ritornato a casa, ripromettendosi di tornare la settimana seguente. Tuttavia, poiché anche la seconda visita si era rivelata un ulteriore buco nell’acqua, il figlio della Perrocchio aveva iniziato a pressare con precise e insistenti domande i Trasselli. Questi, o non sapevano, o fingevano di non sapere, in ogni caso non lo avevano aiutato di certo a venire a capo della faccenda. Risultava solo che la donna era sparita da troppo tempo e senza lasciare traccia di sè. Unico
indizio, il suo nuovo uomo di fiducia, il capomastro Antonio Boggia, abitante in
via Nerino, che a detta degli inquilini era da parecchio tempo in gran
confidenza con la proprietaria. Lo aveva conosciuto, gli dissero, quando aveva
cercato nella contrada un buon muratore per eseguire piccoli lavori di
manutenzione al caseggiato, ed in breve tempo era diventato il suo
amministratore. Il Maurier, che sentendo questi racconti era rimasto sbalordito, raccontò in Tribunale di come avesse rintracciato l’uomo, dal quale, tuttavia, aveva genericamente appreso che la madre era in vacanza dalle parti di Como, e che lui amministrava il palazzo secondo le istruzioni che riceveva per lettera dalla donna stessa. A prova di ciò aveva mostrato, appunto, alcune missive, anche recentissime. Rassegnatosi alle stranezze della madre, Giovanni Maurier aveva infine rinunciato ad ogni ulteriore indagine, in considerazione anche del fatto che una sua iniziale denuncia presso la Questura non aveva sortito alcun effetto, poiché il Boggia, convocato negli Uffici di San Gottardo, aveva spiegato di essere regolarmente munito di mandato con rappresentanza per gestire l’immobile, e che degli screzi tra madre e figlio non poteva essere al corrente. Il
racconto del Maurier si fece più interessante quando narrò il seguito, cioè
del giorno in cui Antonio Boggia e un suo aiutante gli avevano fatto visita per
sottoporgli un’interessante proposta: poiché la madre aveva deciso di
affittare il palazzo per un lungo periodo di tempo ad un unico conduttore,
avrebbe lasciato in comodato all’unico figlio l’appartamento del secondo
piano, quello da lei abitato, visto che, per il futuro, avrebbe risieduto
definitivamente sul lago di Como. Il
Maurier ammise durante la deposizione che, per leggerezza e forse per cupidigia,
da quel momento aveva smesso di sospettare del Boggia, felice del fatto che la
madre si fosse finalmente rinsavita e che a suo modo, forse, avesse deciso di
farsi perdonare. Questi i fatti narrati dal Maurier, fatti che al giudice Crivelli, cui venne affidata l'istruttoria, dovettero apparire molto gravi e circostanziati. Il Boggia, timorato di DioIn
seguito alla denuncia del Maurier, venne formalmente aperto un fascicolo a
carico di Antonio Boggia. Questi era nato il 23 dicembre 1799 a Urio, sul lago
di Como, paese che aveva però definitivamente abbandonato nel 1818. Dopo un
passato di piccolo imprenditore edile a Milano, aveva conosciuto il fallimento e
si era per questo rifugiato in Piemonte. Anni dopo aveva fatto ritorno in città,
dove aveva preso alloggio prima in via Montenapoleone, poi in via Nerino, e ivi
abitava, vedovo e con dei figli. Dalla
vecchia denuncia risultava che il 3 aprile 1851 il Boggia aveva invitato il
pover’uomo, con la scusa di farsi controllare dei conti, presso un suo piccolo
magazzino, sito nella stretta Bagnera (tutt’ora esistente, ma dal 1865
ribattezzata col più moderno termine di "via"). Mentre quello era
chino sullo scrittoio, il Boggia gli aveva assestato un forte colpo di scure in
testa, tramortendolo. L’uomo, riavutosi, aveva avuto la forza, benchè
sanguinante, di scappare in strada, inseguito dal Boggia inferocito.
Fortunatamente aveva incontrato nelle vicinanze un suo conoscente della guardia
di finanza, che lo aveva soccorso e fatto arrestare il Boggia. Le indagini si fanno serrate…Il
Boggia, benché interrogato pressantemente e messo di fronte alle sue presunte
responsabilità, si chiuse in un mutismo esasperante, trincerandosi dietro a
tanti "non ricordo", "non so", "oh la mia povera
testa". Ma ascoltando i portinai di Santa Marta, finalmente il giudice
Crivelli cominciò a vederci un po' più chiaro. Il
Trasselli ricordò di aver visto l’ultima volta la Perrocchio il giorno
in cui il Boggia si era presentato di buon mattino per aggiustare il tetto dello
stabile. Più tardi il capomastro gli aveva chiesto, per certi lavori, di
portare al primo piano alcuni secchi d’acqua. Fu subito disposta una perquisizione del caseggiato, per sostenere l’agghiacciante ipotesi: il Boggia avrebbe ucciso quella stessa mattina la Perrocchio, poi l’avrebbe seppellita nel palazzo (impossibile che si fosse aggirato per la città con un cadavere sulle spalle) e successivamente, con falsa procura, avrebbe amministrato il palazzo.
Ma la storia era finita. O meglio, la storia della Perrocchio, perché il Boggia sulla coscienza aveva altri omicidi. Gli altri criminiIl giudice Crivelli, proseguendo nelle indagini, dispose un sopralluogo nel locale della stretta Bagnera, dove furono trovate le false lettere della Perrocchio e il mandato a rappresentarla. Tra le carte
custodite in uno scrittoio, saltarono fuori altri due mandati rilasciati al
Boggia: il primo da un certo Serafino Ribbone, l'altro dal ferramenta Meazza.
Inoltre, mettendo insieme vecchie denunce e tenendo in debito conto le
dichiarazioni spontanee di alcuni testimoni, si appurò che un commerciante,
scomparso ormai da qualche anno, negli ultimi giorni era stato visto confabulare
col Boggia di certi affari. Quest'ultimo, naturalmente, negava tutto,
lamentandosi delle ingiustizie che era costretto a subire, diceva, per vendetta
del notaio Cattaneo, che gli serbava rancore dalla volta in cui si era rifiutato
di predisporre la procura della Perrocchio. La prima vittima
In verità, ben due procure risultavano rilasciate dal Ribbone, dato che il primo mandato generale, rogato dal notaio Gaslini di Milano, non era stato ritenuto valido, e la cugina del Ribbone si era inizialmente rifiutata di consegnare i soldi custoditi al Boggia. Solamente con un secondo mandato, questa volta speciale e rogato dal notaio Terzaghi di Lodi, la donna si convinse a consegnare il denaro (ma dopo essersi informata e ottenuto il parere favorevole di un pretore circa la validità dell'atto stesso). Pare che il Boggia l'avesse poi rassicurata, raccontandole che quei denari occorrevano al Ribbone per sposarsi in quel di Lodi. Naturalmente, mai il povero Serafino Ribbone aveva incaricato Antonio Boggia di effettuare tale prelievo. Probabilmente, e con un pizzico di ingenuità, egli lo aveva solo reso partecipe della piccola fortuna accumulata e depositata presso la cugina, dopodiché al resto ci pensò il Boggia: lo aveva ucciso attirandolo nel suo solito magazzino degli orrori con una scusa, si era procurato un amico disposto a spacciarsi per il Ribbone, due soliti compari falsi testimoni, e innanzi a ben due notai aveva ottenuto il mandato onde carpire i denari del poveretto. La seconda vittimaNon aveva invece dovuto scomodare notai e testimoni per derubare la sua seconda vittima, il furbo Boggia. Gli era bastato frequentare le aste pubbliche, ed addocchiare un benestante mediatore di granaglie, tal Marchesotti. Questi, avvicinato presumibilmente dal Boggia proprio durante una sessione d'asta, doveva essere stato attirato in trappola con una storiella di facili guadagni, per ottenere i quali era però necessario un capitale iniziale di 4.000 svanziche. Si deve credere che il Boggia fosse molto astuto e preparato, se poteva convincere della bontà di un affare un uomo esperto e navigato come il Marchesotti, che sulla piazza non era l’ultimo arrivato. Unica certezza
era che del mediatore si erano perse le tracce il 15 gennaio 1850, una sabato,
quando di buon’ora era uscito di casa, dalle parti di San Marco, con in tasca
i denari occorrenti ottenuti in prestito il giorno prima da un conoscente, per
recarsi all'appuntamento d'affari. Testimoni lo videro quella mattina in
un’osteria di Ponte Vetero, in compagnia del Boggia, poi entrambi si erano
allontanati assieme. All'epoca il tutto era stato presto archiviato, essendosi creduto che l’uomo fosse deliberatamente fuggito da Milano coi soldi. La terza vittimaNel 1851 il
Boggia era entrato in contatto con il fabbro Pietro
Meazza, proprietario di una bottega con alcuni dipendenti dalle parti del
Carrobbio. Poiché l'impresa navigava in brutte acque, il fabbro si era rivolto
al Boggia, presentatogli da tal Binda, amico comune, come uomo serio ed onesto,
capace di destreggiarsi negli affari come nessuno. Anche queste denunce erano cadute nel vuoto, visto che all’epoca rintracciare uno scomparso doveva essere, dati i mezzi tecnici, impresa alquanto disperata. L’unica
certezza era che il Boggia, per un certo periodo, aveva effettivamente
amministrato l'impresa e pagato regolarmente i lavoranti. Poi aveva venduto
tutto al Binda per una cifra inferiore al reale valore dell’attività. I pochi
soldi, teoricamente, sarebbero andati al Meazza, ma era ormai chiaro, alla luce
delle indagini, che il pover’uomo non aveva mai visto quel denaro, né più la
luce del sole. La terribile scopertaAl giudice Crivelli dovette apparire abbastanza evidente che oltre alla Perrocchio il capomastro di via Nerino aveva fatto sparire almeno altre tre persone, e tutte per derubarle. Il problema era trovare le prove, vale a dire i cadaveri delle vittime. Senza alcun
valido elemento per orientare le ricerche dei corpi, le indagini caddero sulla
stretta Bagnera, per almeno tre ragioni: innanzitutto perché il locale che il
Boggia usava come magazzino e ufficio era da lui solo frequentato. Secondo, la
via Bagnera era (ed è tutt’oggi) un budello a forma di L, ove era impossibile
il passaggio di carri e carrozze, e dove anche i passanti erano scarsi. Terzo,
il tentato omicidio del Comi si era consumato proprio in quello stanzone.
Il processoIl capomastro
divenne per tutta la città "il mostro della via Bagnera" o
"della via Nerino", tanto da diventare il protagonista di raccontini
popolari e di macabre rappresentazioni teatrali scritte per il popolino. A pochi tuttavia i suoi delitti apparivano in sintonia con la mente di un folle, che uccideva colto da raptus, come l’accusato sosteneva ("ero preso come da un raptus"). Innanzitutto perché gli omicidi erano sempre legati a guadagni consistenti e illeciti, poi perché i piani che ogni volta il Boggia aveva architettato erano degni di un professionista della truffa e del crimine. Al termine dell'istruttoria, al Boggia vennero contestati i seguenti capi di imputazione: - omicidio a
scopo di rapina di A. S. Ribbone, avvenuto nell'aprile 1849; A questi reati si aggiunsero le tentate truffe e le sostituzioni di persone in atti pubblici. La sentenza di morteIl processo si aprì il 18 novembre del 1861, e durò cinque giorni. La difesa aveva giocato tutto sull'infermità di mente, basandosi anche sulla prima assoluzione avvenuta all'epoca dei fatti relativi al Comi. Al termine tuttavia venne emessa prevedibile sentenza di condanna a morte. Il successivo
ricorso in Appello fu respinto, e verdetto negativo diede anche il tribunale di
terza istanza. Neppure il re volle concedere la grazia. Il giorno
dell'esecuzione, Antonio Boggia fu fatto salire su di un carro coperto da
un'intelaiatura di stoffa nera assieme ai boia, e fu portato, tra ali di folla
curiosa e feroce, fuori città. Il mesto corteo, composto anche dalle carrozze
degli alti funzionari del Tribunale e dei rappresentanti della commissione
carceraria, si fermò all'altezza dei Bastioni, in uno slargo tra porta
Vigentina e porta Ludovica. Qui, davanti ad una marea di uomini, donne e, come
poi deplorato dalla stampa, ragazzini, Antonio Boggia fu impiccato.
BibliografiaLuzzi, Giovanni, Il giallo della stretta Bagnera, Libreria Milanese 1999; Gazza Franchini A., Antonio Boggia il mostro di Milano, in "Historia", n. 172, 1972.
Ultima modifica: lunedì 26 ottobre 2009 maucolombo@hotmail.com |
||||||